Oggi è tra i vitigni autoctoni del Trentino Alto-Adige ma la sua storia è lunga e ancora poco chiara, nonostante si ritenga che il suo arrivo in Italia sia stato in concomitanza con l’invasione Longobarda del 568. Ancor meno chiara è l’etimologia del nome, la quale, in definitiva, è riconducibile alla forma di allevamento a cui il vitigno Schiva era sottoposto, ovvero in filari (costrette – schiave). Le varietà di Schiava oggi più diffuse e conosciute sono: la Schiava grossa (Margellana o Patriarca) con il grappolo grande, la Schiava gentile con il grappolo piccolo e la Schiava grigia. Nonostante le tipologie ed i “biotipi” di Schiava siano numericamente maggiori delle tre precedenti, le sue caratteristiche di trasformazione si possono accomunare nella seguente sintesi: vini dal colore poco intenso e di poca forza, caratteristica che spesso porta i produttori ad usare altri vitigni per conferire finezza al vino. Dal punto di vista ampelografico, invece, le varietà sopra citate si presentano:
- Schiava grossa: la foglia è grande, pentagonale e trilobata; il grappolo è grande, tronco-conico, compatto e alato. La bacca, appunto, “grossa” è scura – tendente al nero-blu.
- Schiava gentile: ha foglia media, orbicolare mentre il grappolo è medio, piramidale ad ala, spargolo con peduncolo lungo e sottile. La bacca è di colore blu-viola.
- Schiava grigia: anch’essa ha foglia media, pentagonale, trilobata (o intera). Il grappolo è medio, piramidale allungato e spargolo. La bacca, media, ha colore blu grigio.
Per tutte e tre le tipologie, inoltre, c’è una ricca presenza di pruina e la raccolta avviene verso la metà di settembre.
DOC Trentino: Alto Adige sudtirol, DOC Lago di Caldaro
Le migliori trasformazioni di Schiava su Vino75.
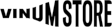



Lascia un commento